Intervista all’avvocato Angela Petraglia, impegnata nel settore ICT e Nuove Tecnologie
La tecnologia blockchain è una tecnologia disruptive che consente di registrare e tracciare qualunque tipo di transazione tra le parti che partecipano all’ecosistema, indipendentemente dalla loro ubicazione fisica. E’ determinante inquadrarne il modello di business e la visione strategica per mettere a sistema tutti i processi organizzativi e applicare la blockchain quale passaggio di un processo organico. Senza ricorrere ai classici casi d’uso relativi alle transazioni di criptovalute, pensiamo a casi concreti di vita comune. L’acquisto di un’auto usata suggerisce la verifica delle caratteristiche tecniche (km, precedenti revisioni, originalità dei ricambi etc), suscettibili di alterazione da parte del l’uomo. L’adozione del protocollo informatico blockchain consente di superare ogni dubbio: i dati inseriti sulla catena di blocchi sono verificabili da tutti in piena trasparenza, immodificabili, contengono una data certa relativa al loro inserimento tramite l’apposizione di un time stampe sono identificati univocamente da una funzione matematica, l’hash. Possiamo dunque ricostruire con certezza ogni passaggio. Se poi volessimo associarvi un prodotto assicurativo per ottenere sconti sul premio ad una data condizione (es. km effettivamente percorsi), potremmo adottare uno smart contract per trasferire i dati onchain direttamente alla compagnia assicurativa, consentendo la verifica automatica delle condizioni necessarie all’ottenimento dello sconto e la sua effettiva applicazione. Nel setto re della logistica è determinante dare trasparenza e monitorare le catene di approvvigionamento tra produttori, rivenditori, distributori, trasportatori, fornitori e i consumatori, spesso distribuiti in di verse località del mondo. Le caratteristiche tipiche di tracciabilità della tecnologia blockchain sono performanti a tale scopo, in particolare nei processi di filiera, dall’agrifood al settore moda, ove semplificano l’attività delle aziende anche dal punto di vista burocatrico. Nel settore del trasporto merci possiamo pensare all’adozione della blockchain per monitorare il mantenimento della catena del freddo, essenziale alla corretta conservazione dei vaccini. Si consideri poi che la blockchain può essere interoperabile con altre tecnologie, impattando significativamente nella vita quotidiana di una smart city.
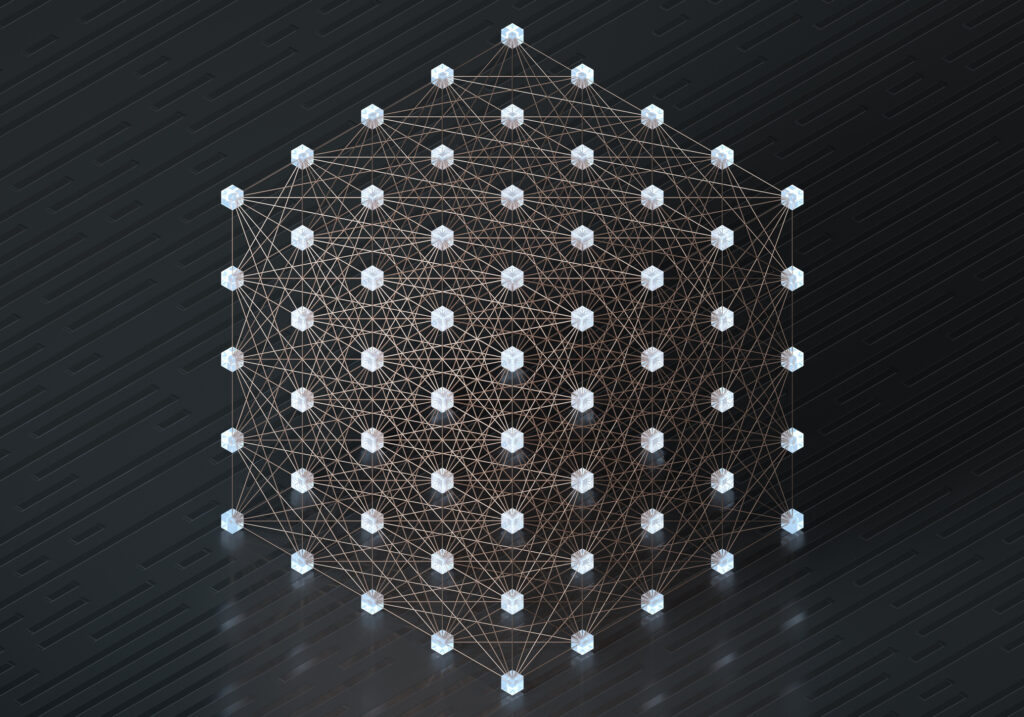
Come evolve il diritto in materia, in particolare in rapporto alla velocità di trasformazione del settore tecnologico?
La trasformazione digitale è un’opportunità senza pari. La pandemia Covid – 19 ha evidenziato la necessità di addivenire ad una quadro normativo più maturo al livello sovranazionale, in tema di nuove tecnologie e in generale di Information and Communication Technologies. Occorre uniformare i diversi orientamenti che gli Stati Membri hanno adottato negli ultimi anni, anche sul tema blockchain. L’incertezza normativa genera infatti scetticismo e falsi luoghi comuni, rallentando la diffusione e comprensione dell’innovazione in corso. In linea generale, l’Unione Europea sposa il principio di neutralità tecnologica e di non discriminazione, scegliendo di non preferire alcuna tec nologia per poter adattarsi alle tecnologie che emergeranno, con previsioni a maglie larghe, pur sot to forma di Regolamento di immediata applicazione. Il General Data Protection Regulation (Reg. UE 679/2016) offre molti spunti di riflessione per affrontare il complesso intreccio di relazioni tra il trattamento dei dati personali e la blockchain, ancora molto dibattuto da tecnici e giuristi, con orien tamenti contrastanti. Occorre partire da una valutazione organica del fenomeno tecnologico che im patta a 360 su istituti giuridici di diversa natura, in relazione al caso concreto. A tal fine sarà essen ziale l’opera ermeneutica del giurista munito anche di competenze tecnologiche che gli consentano
di scandagliare ogni singola questione che il medesimo oggetto tecnologico potrebbe porre in concreto. Debbono essere considerate normative europee, nazionali e di settore, i codici di condotta e linee guida ove esistenti, le ISO, gli orientamenti degli Organi di Vigilanza, le prassi e così via. L’evoluzione tecnologica come sappiamo è inarrestabile ma dobbiamo considerare che anche l’evoluzione normativa (sia in termini di fonti del diritto sia in termini di soft law e delle prime pronunce delle Autorità Garanti prima ancora che dei giudici di merito) ha subito un’accelerazione improvvisa ancora in rapida crescita. Dal punto di vista blockchain, l’Italia si fregia di essere stata pionera del riconoscimento di valore legale del genus DLT, pur non esprimendosi in esplicito sulla species blockchain che si intende però in essa ricompresa (art. 8 ter Decreto Semplificazioni n°135/2018 convertito in Legge n°12/2019). Il Mise ha predisposto una Proposta per la Strategia italiana in materia di tecnologie basate su regi stri condivisi e Blockchain e di recente la CONSOB ha annunciato l’introduzione in Italia della prima sandbox regolamentare (dedicata al settore FinTech) per testare soluzioni innovative nei set tori bancario, finanziario e assicurativo, tra cui anche la blockchain. Ogni altro aspetto viene rimandato ad un successivo approfondimento.
Pensiero computazionale, gaming, virtual reality, augmented reality, robotica collaborativa aspetti, apparentemente specialistici, ma che in realtà fanno parte del vissuto collettivo contemporaneo
Stiamo vivendo nel pieno della quarta rivoluzione industriale in cui assistiamo ad una forte contaminazione tra mondo fisico e mondo digitale. Ogni persona fisica, anche la meno avvezza alla tecnologia, è rappresentata in qualche misura nel mondo online e i dati ad essa riferiti hanno un valore economico. La direzione è irreversibile. E’ necessario acquisire consapevolezza del fenomeno tecnologico e offrire strumenti agili e alla portata di tutti ai fini della sua comprensione, per non subire la tecnologia, ma cavalcarla.
Il pensiero computazionale e coding sono già stati inseriti come programmi scolastici indispensabili alla formazione delle nuove generazioni poiché consentono lo sviluppo delle capacità critiche di problem solving indispensabili per ragionare in termini digitali. Il gaming è assodato ormai come strumento utile non solo in contesti educativi ma perfino aziendali per potenziare l’apprendimento e lo sviluppo di nuove competenze professionali tramite il coinvolgimento attivo dei partecipanti (cd. serious game).
Le soluzioni di VR e AR sono sempre più adottate per valorizzare il nostro patrimonio artistico cul turale, ma anche in campo sanitario quale valido ausilio all’attività chirurgica ad esempio. Ancora la domotica e la robotica collaborativa (ancora allo stato primordiale) stanno acquisendo sempre mag
gior spazio nelle nostre vite, pensiamo più banalmente ad un assistente vocale. Ogni aspetto della nostra vita è pervaso ovunque dalla tecnologia, dal bar, all’ufficio pubblico per tanto occorre sensibilizzare e confrontarsi sui temi legati al digitale (e non solo alla tecnologia in senso stretto), sulle implicazioni giuridiche dell’adozione di questi strumenti e sull’etica che deve guidare il nostro agire anche online. I nostri dati sono il nuovo petrolio. Sapere è potere.

E le politiche stanno realizzando un allargamento del capability set di chi ha meno opportunità?
A ben vedere, infine, mentre tutta l’economia politica è costruita sul paradigma dell’homo economicus, cinico ed egoista, Sen propone una visione nella quale ha spazio l’etica e la solidarietà anche nel comportamento degli agenti economici. Le conseguenze sono assai rilevanti e c’è da sperare che venga presto sviluppata una teoria economica seniana, alternativa a quella ortodossa che tanti danni ha contribuito a generare nel nostro mondo.

